L’arte come téchne
Nel 2003 moriva Stan Brakhage. Si può dire, come per il Nicholas Ray di Lightning Over the Water (Lampi sull’acqua, 1979), che morisse della sua stessa arte. Per un cancro probabilmente provocato dall’uso delle tinte con cui incideva le pellicole. Come racconta P. Adams Sitney nel suo obituary1, appena uscito dall’anestesia, dopo il suo intervento chirurgico, Brakhage è riuscito ancora, per l’ultima volta, a utilizzare una 16mm e a filmare il palmo della mano per alcuni secondi, per confermare che era vivo e che la sua arte ha sempre fatto corpo con la sua vita. Una dichiarazione ero(t)ica e, insieme, un manifesto del suo stile di vita. Quello che Merleau-Ponty ha scritto per Cézanne si potrebbe dire anche per Brakhage. “La pittura [La prassi filmica] è stata il suo mondo e la sua maniera d’esistere”2.
Dispiegata fra il 1952 e il 2003 la filmografia di Brakhage – 400 film circa (quasi tutti sempre in 8mm e 16mm) – è un continente della storia del cinema in cui si possono individuare livelli distinti e correlati che ne costituiscono la trama, attraversata da temi come la nascita, la morte, il sesso e la ricerca di Dio. Il livello della lunga durata, cioè di una costante vocazione a difendere i diritti di una percezione che è già espressione, di un occhio liberato, che attraversa tutti i suoi film dalla prima fase di crudo realismo e crudele espressionismo fino all’astrattismo degli ultimi anni. In questo senso il suo cinema è l’incarnazione del suo manifesto: Metaphors on Vision. La visione che tocca gli estremi, come direbbe il Merleau-Ponty di L’Œil et l’Esprit3. La visione di un visibile in cui si muove qualcosa che invade il corpo del vedente come se la visione del visibile si formasse nel vedente, in cui non c’è rottura fra uomo e natura, non c’è confine tra vedente e visibile. La visione non come pensiero o presenza a me stesso (una presenza sottratta alla differenza e idealisticamente identica a sé), ma la visione come una fissione dell’Essere a cui il vedente assiste dall’interno. È la tensione dominante tutto il suo cinema, la sua longue durée, la struttura che configura la sua opera. L’avventura della percezione irriducibile alle leggi della prospettiva rinascimentale e al convenzionalismo pigro e confortevole del nominalismo.
L’occhio disarcionato dal logocentrismo
L’arte di Brakhage, pur essendo costruzione di forme o espressione di esperienze che destano meraviglia, commuovono e scuotono4, eccede il concetto di Bello come decor, venustas, aptum, equilibrio, misura, serenità, insomma il bello classico. Certo un’arte più romantica che classica, in cui tende a venir meno l’uniformità e in cui si tende a cogliere la profondità dell’essere nella superficie dei fenomeni, romantica perché il bello non è la categoria predominante ma è correlato in una corrispondenza che lo fa giocare con l’intensità, il sublime, l’estro5. Un’arte, che si inscrive consapevolmente nel visionary film, nel cinema americano d’avanguardia inaugurato da Maya Deren, che a sua volta si ispirava a Un chien andalou, ma che anche se ne distanziava. In fondo sia la Deren che Brakhage devono molto più a Jean Cocteau, critico del Surrealismo, e al suo Le sang d’un poète. Su Cocteau, Brakhage ha scritto: “my initial filmic mentor”. Brakhage è sempre stato disponibile a riconoscere i suoi debiti nei confronti di Cocteau e di Marie Menken, verso la Deren ovviamente, e per il Joseph Cornell filmmaker: “I was never inspired in my work by Joseph Cornell’s boxes or collages – only, essentially, by his compleely film distinctive films”6.Ma al di là dei debiti contratti con Maya Deren, Joseph Cornell e Marie Menken, il cinema di Brakhage sembra entrare straordinariamente in risonanza con la pittura di Paul Cézanne, quindi con l’origine del Modernismo. Come Brakhage, anche Cézanne, attraverso la praxis poietica, ha ristrutturato la nozione di forma come ordinatio, dispositio, symmetria, una nozione platonica, agostiniana, ma anche rinascimentale. Pur non mancando di forma né il cinema del primo, né la pittura del secondo, le opere dell’uno e dell’altro sono certamente composizione di parti presentate ai sensi. Ma non si tratta di una forma proporzionata o ben proporzionata, una forma ben fatta, come direbbe Lyotard, del “buon arabesco” di cui parlava Etienne Souriau.
Tympanum e loxos
Se Warhol è lo sguardo macchinico dell’avanguardia americana, Brakhage ne è l’io, senza parlare né utilizzare alcun suono. I suoi film sono quasi tutti silent movies (Desistfilm, The Stars are Beautiful e In Between, musicato da John Cage, per esempio hanno un soundtrack), eppure il suo cinema è musica per gli occhi, la lingua originaria del tutto inarticolata, la lingua delle pietre che urlano, è luce delle orecchie che risveglia lo spettatore disabilitato a vedere e ad ascoltare, cieco ai suoni e sordo alla luce. I film di Brakhage, anche se silent, vanno ascoltati e non solo guardati. Nel suo cinema riaffiora una sonorità cosmogonica, la meraviglia di un mondo allo stato nascente, ecco perché la sua arte è intrinsecamente annodata al mito che come sapeva bene anche Aristotele sempre ha a che fare con l’origine e sempre desta stupore, l’atteggiamento, la tonalità emotiva di colui che è aperto e accoglie. Il suo cinema è un rito (il rituale della nascita di un bambino in Window Water Baby Moving o della morte di un animale fedele in Sirius Remembered), la lingua inarticolata dei Veda, è tympanum, il corpo che canta senza tenersi ordinatamente nel limes. Il timpano di Brakhage è lacerato e fessurato dall’altro che deborda ogni confine. È una soglia. La sua “scrittura” si gioca in bilico sulla frontiera dell’identità, è violenta, sconvolta, pluralizzata, polivalente, irriducibile al logos perché poli-logica, consumata nell’andirivieni metamorfico fra il divampare e la pace.
Brakhage fa lavorare il loxos nel logos, l’obliquo e il teso nella rappresentazione, altrimenti frontale e simmetrica, come se il soggetto fosse dinnanzi all’oggetto pronto alla cattura. Nondimeno è sempre questo timbro, lo stile di Brakhage a rendere ogni evento possibile, la logica dell’evento è interrogata a partire dall’arte, dalla sua arte e dalle sue strutture, poiché tutto si può dire di Brakhage, tranne che sia naïf, piuttosto coltivato: l’incipit di un articolo apparso su Film Culture7 parlava di grande disciplina Le sue materie pellicolari diventano il luogo in cui si congiungono e disgiungono noccioli, matrici, voci, ammucchiati in un inviluppo in cui sono implicati. La prassi artistica di Brakhage, prendendo a prestito Derrida8, è sia dentro che fuori quel margine che interroga, anzi, il margine stesso è dentro e fuori. Dentro, perché l’arte di Brakhage è disciplinata, metodica, è una cura, a sua volta insomma un “discorso” che vuole-dire ma che si eccede da sé.
L’occhio e l’orecchio
Secondo l’autorevole, documentata e misurata ricognizione di David E. James, che dedica un capitolo a Stan Brakhage nell’importante Allegories of Cinema9, l’avanguardia americana del secondo dopoguerra è più pertinentemente interpretabile nella connessione con la poesia che non con la “pittura astratta”. Fu Hans Ricther, artista e cineasta europeo – prima di Jonas Mekas e P. Adams Sitney – autore dei corti Rhythmus 21, Rhythmus 23 (1923), Rhythmus 25 (1925). a chiamare «film poem» il cinema d’avanguardia in un articolo pubblicato su Film Culture nel 1957, la rivista pubblicata da Mekas e vangelo del nuovo cinema underground. Secondo Richter – che in America aveva girato Dreams That Money Can Buy (1947) – il film d’intrattenimento (hollywoodiano, narrativo) era paragonabile al «novel», mentre il film d’avanguardia era lirico, sul versante della «poetry». Qualche anno prima, in occasione di un simposio organizzato a New York presso il Cinema 16 di Amos Vogel10 – infaticabile e leggendario promotore del cinema d’avanguardia e autore del fondamentale Film as a Subvervive Art, Parker Tyler – uno dei primi storici dell’avanguardia americana e autore di Undergorund Film. A Critical History11 – distingueva due gruppi di artisti impegnati nella “poetical expression”: da un lato i surrealisti (“poetry as visual medium”) e dall’altro Vigo, gli americani come Maya Deren, ma anche Ejzenstejn (“poetry as visual-verbal medium”). Maya Deren, canonicamente considerata l’iniziatrice dell’avanguardia americana, ha scritto il cinema narrativo – il dramma – è orizzontale, mentre quello poetico è verticale. Non si può celare il fatto che in tale dibattito, denso e ricco di riferimenti, e che indubbiamente impreziosiva la cultura americana di quegli anni, non risuoni come un’eco crociana. Infatti l’italiano Benedetto Croce – che al cinema si è sempre poco dedicato, “delegando” un suo allievo non poco brillante, Carlo R. Ragghianti – distingueva fra poesia e letteratura (poesia e non-poesia che non è necessariamente anti-poesia che, anzi, designa il brutto). Una differenza che, ricorda lo stesso Croce nel suo La poesia (1936)12, si è venuta approfondendo in età romantica. In estrema sintesi, secondo il filosofo napoletano, la poesia è più rara della non-poesia, cioè della letteratura, e la differenza “sussiste”. Anche Massimo Bacigalupo, filmmaker sperimentale e critico letterario, nella sua Prefazione all’edizione italiana di Metafore della visione, nel 1970, aveva accostato Brakhage e gli altri filmmaker indipendenti dell’avanguardia alla poesia – e anche alla pittura – citando Olson, Creeley, l’Imagismo, il Vorticismo, Pound. Bacigalupo ipotizza che Brakhage possa essersi ispirato alle canzoni di Pound13 e al Maximus di Olson per le sue Songs degli anni Sessanta14. Brakhage dedica anche due ritratti a due amici poeti protagonisti della contro-cultura americana e della poesia beat (Robert Creeley e Michael McClure) in Two: Creeley/McClure (1965). I due poeti sono ritratti entrambi nel soggiorno dei loro appartamenti, seduti su una poltrona, fumano una sigaretta e accennano un sorriso. Il filmmaker focalizza il suo sguardo sul volto e sulle mani in entrambi i casi, ma i due segmenti – uniti tra loro con un segno grafico – sono tra loro molto diversi anche se entrambi fortemente evocativi dello stile di Brakage. Il primo ritratto è più disteso e intimo. Creeley non era esattamente un poeta beat, ma un protagonista del Black Mountain College, professore universitario e la sua voce poetica era molto calda, tersa e delicata. Il ritratto è un saggio sulla solarizzazione potenziata e moltiplicata dalla sovrimpressione, una meditazione che silenziosamente raccorda molti pensieri, contrassegnata da tonalità più scure e dal nero. Il secondo invece è un saggio del montaggio rapidissimo di Brakhage, una logica delle sensazioni che, come in un dipinto di Francis Bacon messo nel ritmo di una centrifuga in cui baluginano il corpo di una donna nuda e un leone, s-figura, fino alla dissoluzione della svampatina bianca conclusiva, il volto e il corpo del poeta, più r’n’r rispetto a Creeley: McClure era un poeta, cantante e performer beat.
Frammenti di grande confessione (the muses)
Ragghianti, l’allievo di Croce che molto si è dedicato al cinema e alla difesa del suo statuto artistico, argomentava che il cinema in quanto arte è sempre l’espressione di una personalità che si dispiega “sull’accento, sul tono, sullo stile in cui si è configurata, la storia complessa di quell’autore, il suo atteggiamento davanti alla realtà, il suo mondo etico”15: d’altronde anche la “politique des auteurs” è più una stilistica che una teoria. L’osservazione di Ragghianti ben si disegna sulla personalità di Brakhage, tuttavia difetta di un residuo di idealismo che non si addice alla pratica filmica di Brakhage, poiché Ragghianti ridimensiona quella “tecnica” – che si risolverebbe nel processo ideale dell’opera artistica – che invece per Brakhage è sempre stata co-essenziale. Brakhage – che non fu l’iniziatore di tutto ciò (Deren, ma anche Kenneth Anger, Broughton, Jack Smith iniziarono prima di lui), nondimeno fu colui che estremizzò tutti questi aspetti con un’integrità e coerenza senza uguali – nella sua produzione domestica, artigianale, fatta in casa, nella creazione delle sue “tecniche”, materializzava la teoria del film come un’attività interamente personale, una variante della teoria romantica che incontrava anche il sogno “utopista” di William Morris di riconciliare arte e tecnica. La prima fase della sua produzione ne è una conferma. Sitney qualificava il primo cinema di Brakhage, dal 1952 al 1955 circa, come “trance films”: distorsioni spaziali, metonimie utilizzate come metafore, aberrazioni temporali, ma soprattutto la “first-person camera”16, il film come creazione individuale, fatta dalle ossessioni dell’artista, in cui è rinvenibile e ravvisabile uno stile, il suo stile. Il cinema come medium per un’indagine interiore, nel segno del romanticismo. E anche il teorico Brakhage, lo storico del cinema, interpreta la storia della settima arte secondo questa curvatura. Méliès, Griffith, Dreyer, Ejzenstejn sarebbero stati inseguiti da ossessioni che ritroviamo nella rifrazione dei loro fim, sotto forma di avatar. Ejzenstejn per esempio avrebbe lottato contro l’animale che ha devastato il suo essere fin dal grembo. “Some men are caught before their birth by some monstrousness which tears them to pieces of horrible imagination ever after”17. È l’ipotesi Brakahge.
Il cuore dell’essere (in der Luft liegt)
Brakhage, come Cézanne, ha toccato il cuore dell’Essere e della sua pregnanza, della sua carne, la sua profondità e la sua dimensionalità, inquisendo il mistero della realtà dell’immagine che reversibilmente, in un movimento di sfuggimento incessante, è anche immagine della realtà. Una deiscenza fra percezione e mondo, una ferita mai pienamente suturabile. Trascendenza è incarnazione: solidarietà, inerenza fra corpo del mondo e corpo dell’uomo, percezione e movimento. Proprio perché ingranata nel movimento del mondo, la percezione umana si prolunga in esso fino a gonfiarlo come dal di dentro. Mitry, troppo sofisticato, forse troppo accademico o ingessato, troppo influenzato dai giudizi altrui, non ha voluto afferrare questo contatto ombelicale, questo corpo a corpo, questa ferita sanguinante, questa mucosa, questa saldatura mobile, che come le labbra unisce e divide immagine e realtà. E nel cuore dell’Underground americano, allora, ci entra con più curiosità e leggerezza e intelligenza il nostro Alberto Arbasino18, che non era né storico, né teorico del cinema, oppure, nei primi anni Settanta, il critico Enzo Ungari19, che appendeva la superficie e l’esteriorità al collo di Warhol, lo spettacolo espanso che scoppia, mentre agganciava alle immagini di Brakhage la materia e l’interiorità, dove le materie, i resti, la carne del corpo decomposto del suo cane sono l’interiorità, l’intimità, l’anima democritea: Sirius Remembered (1959), un film straordinario, canzonato dal Mitry ma omaggiato da uno dei grandi protagonisti dell’underground italiano Pietro Bargellini, con il suo Stricnina (girato nel 1969 e stampato nel 1973). Per gli amanti del felino – e di Chris Marker – c’è anche il gatto mediatore del rapporto di coppia sottoposto a tensione in Cat’s Craddle (1959), un film in cui
des points lumineux et des reflets changeants sont agencés dans un montage rapide avec des images de Stan et sa femme ainsi que son chat ce qui donne finalement la sensation qu’il joue avec ce dernier à travers le médium film20.
L’espansione ontologica e, anzi, ontogenetica diviene perfetta, culmina in The Act of Seeing with One’s Own Eyes, l’occhio si rivolta, vede se stesso, bergsonianamente e rossellinianamente, la materia vede se stessa. Un essay sulla visione, sul vedersi attraverso i propri occhi come se la materia vedesse se stessa, che sarebbe piaciuto anche a Paul Valéry. In fondo era già il sogno dei Greci.
La percezione mi dischiude il mondo come il chirurgo dischiude un corpo, appercependo, attraverso l’apertura che ha praticato, degli organi in pieno funzionamento, presi nella loro attività, visti di sbieco (…). La percezione non è in primo luogo percezione di cose, ma percezione degli elementi (acqua, aria…), di raggi del mondo, di cose che sono dimensioni, che sono mondi, io scivolo su questi ‘elementi’ ed eccomi nel mondo, passo dal “soggettivo” all’Essere21.
The Act of Seeing è il mondo cézanneano a cui si riferiva brevemente Gilles Deleuze22 à propos di Stan Brakhage. Il cadavere viene eletto a corpo del divenire-artistico, un big bang di metamorfosi, in cui il corpo-senza-organi sprigiona colore e resiste al repertorio e alle pinze. Operazione filosoficamente, ma non figurativamente, analoga aveva sperimentato anche Hitchcock, con successo, ma non di pubblico, negli anni Cinquanta con La congiura degli innocenti (1955)23, forse il suo film più stravagante e filosofico. Il corpo viene investito da dispositivi e pratiche che lo segnano, assoggettano e stabilizzano. Il potere transita nei corpi, diceva Michel Foucault che, tuttavia, aggiungeva: là dove c’è potere, anche c’è resistenza. La soluzione sta nel veleno. Sintomatico di questo paradosso è proprio The Act of Seeing with One’s Own (1971). Il corpo qui è cadavere, oggetto di prese e pinze, cure e dispositivi, non è più un organismo attivo e funzionante, utile, in quanto svuotato di organi dalla pratica dell’autopsia. Il corpo morto, macellato, dissezionato, apparentemente inerme, nudo perché esposto alla giurisdizione delle pratiche mediche, proprio nel culmine di questo strazio, in quanto sfaldato e disarticolato può sobbalzare, sussultare, disgregarsi in un fascio di luci che per sempre lo sottrae alla presa, alla cattura dell’organizzazione mortifera dell’organismo che deve funzionare, gerarchizzato, organizzato, con gli organi funzionanti e asserviti alla logica dell’utile. Con i resti, i pezzi, le rovine, i frammenti del corpo Brakhage interroga ed esibisce lo sguardo di sé su di sé, apre una strada attraverso le fibre tagliate. Un atto di interrogazione, come se la natura cercasse un passaggio attraverso le fasce di quei corpi, come se volesse esprimersi ma secondo i suoi voti.
Morire è far crescere l’erba
L’esemplarità del cinema di Stan Brakhage, dei suoi neri, del suo lavoro sul nero della pellicola, è un radicarsi nel suo stesso suolo, ceppo artistico e, insieme, umano e sovraumano, oltre l’umano. Il supporto – la cinepresa e la pellicola di Brakhage – è incarnazione materiale, è empirico in quanto si inscrive la figura, in fondo è il significante del significato. Ma il supporto è anche trascendentale, cioè è un senso fondatore della relazione fra significante e significato, in quanto è il precipitare invisibile di tutto un mondo, una sterminata antichità di pratiche (umane, artistiche, sociali), come direbbe Vico, attraverso la quale transita il senso e la vita del senso: dall’arte paleolitica delle Grotte di Lascaux fino a Meshes of the Afternoon (1943) di Maya Deren – che tanto magistero ha esercitato su Brakhage – passando attraverso l’invenzione delle cineprese e della materia sensibile (la pellicola), in cammino da Aristotele, dall’oculus artificialis di Leonardo e dalle fotocamere di Gerolamo Cardano e dal cloruro d’argento ottenuto da uno scienziato tedesco all’inizio del Settecento, dagli esperimenti di un ceramista inglese all’inizio dell’Ottocento sul nitrato d’argento fino a Niépce e Daguerre…
Il nero di Brakhage è l’entroterra, l’ampia notte. Non a caso quello scienziato tedesco aveva chiamato la sua materia fotosensibile scotophorus: portatrice di tenebre. La luce nera, a Gilania, come ha spiegato Marija Gimbutas, prima dell’avvento violento delle tribù indo-europee, era il simbolo della Grande Dea, grotta umida e suolo fertile. È la luce nera a cui Brakhage si abbevera per risalendo alla fonte, alla scaturigine attraverso la sua stessa arte, la sua “scrittura”, come se la fonte fosse l’effetto di ciò di cui essa è l’origine. Secondo Paul Valéry la fonte è l’io. L’origine è départ: inizio, partenza, ma anche distinzione, differenza. Ma l’io in quanto fonte di promanazione è anche, al tempo stesso, provenienza e proviene da qualcosa che non è io, non è umano o antropos. L’anteriorità ontologica in Brakhage è inquisita sul terreno dell’io che è altro da sé. La voce dell’io promana da sé e rimbalza su di sé come se provenisse da altro, da fuori, facendo della fonte stessa un oggetto, avvolgimento che propriamente istituisce l’io che si riconosce altro (la voce che proviene) a partire da sé (la voce che proviene): l’io è oggetto del suo stesso evento. Ma questo io già attesta che c’è altro, un fuori. Un esercizio auto-bio-grafico, secondo la lezione del Trascendentalismo: “il sapere della vita che scrivendosi si guarda, si comprende e si perde” (Carlo Sini).
Moving visual thinking
E allora siamo risospinti (da Heidegger) a Emerson – che ha influenzato molti importanti filmmaker americani24 – all’irriducibilità della singolarità, all’auto-bio-grafia, alla casa, al parto, al coito di coppia, al ménage familiare, al cane morto e seppellito, alla scrittura, alla grafica, all’incisione, al taglio, anche senza macchina da presa, col bagno d’acido, le bruciature, le tinte colorate, facendo cinema con tutto se stesso, anima e corpo. È un oltraggio, un’impudicizia, oltre che un’imprudenza, non averlo compreso. Soprattutto dinnanzi alla messa a nuda estrema e coraggiosa di un artista che espone tutto se stesso, manifestando l’incanto di un pensiero cosmico ma situato, radicato e conficcato nel corpo. Un pensiero visivo e in movimento che Brakhage chiamava “moving visual thinking”.
Con The Act of Seeing with One’s Own Eyes, all’inizio degli anni Settanta, il cinema fa vedere tutta la stranezza del corpo, la sua irriducibilità al potere, ai dispositivi cartesiani di chiarezza e distinzione. A dispetto dell’inquadratura il cinema fa vedere il divorarsi di un corpo, il suo estirparsi e consumarsi, la sua degradazione e decomposizione che, ancora una volta, è sottrazione al potere di controllo e alle sue pinze. L’ontologia diventa politica. L’occhio si rivolta al suo interno per vedersi da sé. E il cinema fa vedere, e “sentire” tutta la sua sofferenza. Fino a vedere la luce stessa e farsi luce poiché l’occhio medesimo è luce. Negli anni Settanta, epoca in cui da qualche anno ormai l’avanguardia americana era caratterizzata se non domianta dal film strutturalista secondo l’espressione coniata da Sitney, o strutturalista-materialista come dice Peter Gidal, Brakage realizza un miracoloso saggio sulla luce come potenza ontogenetica. (E a proposito di ontologia, di passaggio: alcuni contrappongono Paul Sharits, Michael Snow e Hollis Frampton a Brakhage, come se i primi fossero interessati solo alla meccanica dello sguardo della cinepresa e il secondo solo ad una supposto psicologia dell’occhio; a questo punto dovrebbe essere chiaro che il cinema di Brakhage semmai è un’ontologia25).
La luna, le stelle, il cielo, la notte, il colore,
la luce nera, la vita, la morte e il gioco del mondo
Lo stile di Brakhage è la sua stessa vita, una forma di vita. Un modo di vita come per i pittori americani dell’action painting e dell’espressionismo astratto, pittori d’azione come diceva Harold Rosenberg che, al di là del trattamento sensuale della materia, del gesto, del dripping, infondono nella pittura l’energia, il vitalismo, la loro stessa vita, spesso drammaticamente come nel caso di Pollock e Rothko. La rivelazione è contenuta nell’atto con cui l’artista impiega la sua energia intellettuale ed emotiva, secondo le parole di Harold Rosenberg26, che è gesto di liberazione e affermazione di sé – anche dai tratti tipici del sé individuale – e che assume anche la forma del Mito: il mito di sé, il mito della liberazione, il mito della conversione. Fede nel mito, dunque, come per Maya Deren e Kenneth Anger e per lo stesso Brakhage, visione di nuovi spazi, un certo senso del dramma, rappresentano le coordinate della dichiarazione d’indipendenza (dall’Europa) di questi pittori: Barnett Newman, Rothko, Sam Francis, Pollock. Analogamente l’avanguardia cinematografica americana in quegli anni andava formulando le sue proprie estetiche attraverso le opere e gli scritti della Deren e dello stesso Brakhage, un’avanguardia che, come ha scritto Bagicalupo27, assimila e fruttifica le avanguardie storiche, ossia europee, ma che è soprattutto «una scoperta del cinema», una nuova invenzione del mezzo con cui agire liberamente e indipendentemente sia dai compromessi con il cinema industriale che dalle mediazioni culturali dell’avanguardia storica. Il cinema di Brakhage entra in risonanza con la white writing di Mark Tobey (pensiamo in particolare alla “Part 1” (1962) di Dog Star Man), con il plenum emotivo di Rothko, il gocciolato e il dinamismo del gesto atletico di Pollock, le cortine luminose di Francis – anche se, evidentemente, Brakhage è più affine all’azione, all’accelerazione e alla frammentazione di un Pollock che non alla “lentezza” del sublime astratto di un Newman e alla morbidezza luminosa e diluita di Mark Rothko.
Non c’è cesura o conflitto, né evoluzione fra il Brakhage lirico della fine degli anni Cinquanta e quello astratto degli ultimi decenni. In The Dark Tower (1999) i tagli abbacinanti, la schermaglia di laser, e le lave di ghiaccio entrano i risonanza proprio con la ferita del venire al mondo, il buco, la fessura che secerne il nascituro (e il mondo) in Window Water Baby Moving (1959), prima di Artavazd Pelechian e del suo Kyanq (Vita, 1993). Un film che è la sua origine del mondo, un film solare, di luce, acqua, zampillante e grondante fluidi, acquatico. L’acqua, come in Terrence Malick, è vita e movimento. E tutto questo dopo le ambiguità del dramma familiare noir di Wedlock House: An Intercourse (1959), chiuso nel dondolare angosciante di luce e ombra: messa in scena di quinte, drappeggi e vapori, quasi un horror familiare che anticipa Strade perdute (1997) di David Lynch e perfino Paranormal Activity (2007). Fino a quando il nodo si scioglie dipanandosi nel sangue della ferita, che è apertura al mondo e non più solo sosta lungo la soglia della finestra che ritorna anche nel sonoro I… Dreaming (1988), con le sue stanze e i suoi bambini, e certo qualche ombra. Fisiologia dell’amore, altro che narcisismo individualista o erotismo fai da te. Il dondolare nevrotico (l’attesa) di Wedlock House diviene pulsazione, respiro e vita in Window Water Baby Moving.
L’albero della vita, che possiamo immaginare nel giardino di Kindering (1987), evoca infatti gli alberi di Anticipation of the Night, in cui la city light è la giostra dei bambini, il gioco dell’infanzia, la giravolta, il girotondo atomistico, prima che scenda la notte nera. Gary Snyder (Source):
Clears up, and all the stars,
the tree leaves catch
some extra tiny source
all the wide night.
Toni D’Angela
Il testo pubblicato è stato estratto e composto a partire da questo libro:
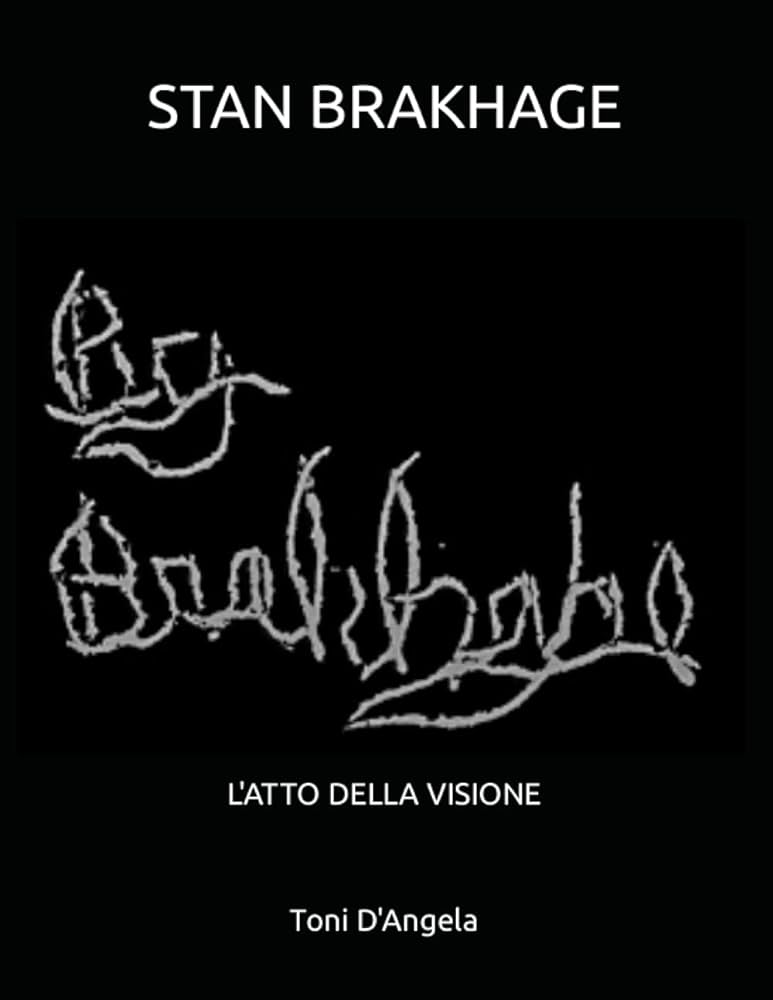
1Disponibile nel website di Fred Camper: P. Adams Sitney, Stan Brakhage, http://www.fredcamper.com/Brakhage/Sitney.html
2Maurice Merleau-Ponty, Il dubbio di Cézanne, in Senso e non senso, Garzanti, Milano 1974, p. 27.
3Cfr. Maurice Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, cit.
4Si tratta certo di una definizione dell’arte istituzionale, come punto di arrivo di una lunga e complessa storia del concetto di arte, rinvenibile per esempio in Wladyslaw Tatarkiewicz, Storia di sei idee. L’Arte il Bello la Forma la Creatività l’Imitazione l’Esperienza estetica, Aesthetica Edizioni, Palermo 1997, p. 67.
5Cfr. Ivi, pp. 201-217.
6Stan Brakhage, Essential Brakhage, Documentext, Kingston, NY 2001, p. 211.
7Cfr. Jerome Hill, Brakhage and Rilke, cit.
8 Cfr. Jacques Derrida, “Timpano”, in Margini – della filosofia, Einaudi, Torino 1997.
9Cfr. David E. James, Allegories of Cinema, cit.; le considerazioni che seguono sono in gran parte ispirate alla linea interpretativa di James.
10Si tratta di un panel moderato da William Maas, a cui parteciparono Maya Deren, Dylan Thomas, Arthur Miller, e Parker Tyler, svoltosi il 28 ottobre 1953, il cui resoconto fu pubblicato su Film Culture dieci anni più tardi. Cfr. http://www.ubu.com/papers/poetry_film_symposium.html. Cfr. “Poetry and the Film”, Film Culture, n°29, 1963. Anche in “Poetry and Film: A Symposium with Maya Deren, Arthur Miller, Dylan Thomas, Parker Tyler, Chairman Willard Maas, Organized by Amos Vogel”,in (a cura di), P. Adams Sitney, Film Culture Reader, Praegers Publihsers, New York 1970.
11Cfr. Parker Tyler, Underground Film. A Critical History, cit.
12Cfr. Benedetto Croce, La poesia, Editori Laterza, Bari 1963.
13Hollis Frampton iniziò un carteggio con Pound e andò anche a fargli visita.
14Cfr. Massimo Bacigalupo, “Prefazione”, cit., p. 18.
15Carlo L. Ragghianti, Cinema arte figurativa, cit., p. 22.
16David E. James, “Stan Brakhage: The Filmmaker as Poet”, in Allegories of Cinema, cit., p. 33.
17Stan Brakhage, The Brakahge Lectures, The GoodLion, Chicago 1972, p. 57.
18Cfr. Alberto Arbasino, America Amore, cit.
19 Cfr. Enzo Ungari, Schermo delle mie brame, Vallecchi, Firenze 1978.
20Doris Peternel, “The Act of Seeing With Stan’s Eyes. Essai sur le cinéma de Stan Brakhage”, La Furia Umana, n° 10,
21Maurice Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, cit., p. 232 (Note di lavoro).
22Cfr. Gilles Deleuze, L’immagine-movimento, cit., p. 106.
23Cfr. Toni D’Angela. “La tessitura del visibile. Su La congiura degli innocenti”, D. D’Alto, R. Lasagna, S. Zumbo (a cura di), La congiura degli hitchcockiani, Edizioni Falsopiano, Alessandria, 2004
24Cfr. P. Adams Sitney, Eyes Upside Down, cit.; in particolare P. Adams Sitney insiste su Marie Menken, Stan Brakhage, Jonas Mekas, Robert Beavers, Hollis Frampston, Andrew Noren, Ernie Gehr, Warren Sonbert, Su Friedrich.
25Sul film struturalista, al di là di semplifici contrapposizioni, si veda: P. Adams Sitney, Visionary Film, cit., Cap. 11: “Structural Film”.
26Cfr. Harold Rosenberg, La tradizione del nuovo, cit., pp. 16-20.
27Massimo Bacigalupo, “Prefazione”, cit., p. 9.
