Parte Prima
Donde il molteplice, il permanere, il fattor comune, la materia, ecc.,
residui della mania di differenziazione da cui è affetto l’universo,
vera idea fissa dell’universo che vuol “provare ogni esperienza,
assaggiare ogni frutto, anche apparentemente malefico”.
Carlo Emilio Gadda
Criticism can subjugate the bestiality of the screen image by breaking
it down into arbitrary but easily managed elements
– acting, story logic, reasonableness, the identifiable touches of a director –
that bring the movie within the doctoring talents of the critic.
Manny Farber
CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA DELL’AUDIO-VISIONE
Un giorno un famoso filmologo rispose ad alcune mie osservazioni critiche al suo discorso teorico assolutamente delimitato ma alquanto distaccato dal contesto storico-politico, replicando che esulerebbe dal campo e dalle competenze dei film scholars prendersi carico delle interconnessioni tra da un lato il linguaggio del cinema e la sociologia delle istituzioni e dall’altro i processi e le relazioni del capitalismo mondializzato. Lo studioso accademico, aristotelicamente, è l’uomo che fa, il grammatico che segue le regole della grammatica – e quelle non codificate dell’Accademia. Delimitare e demarcare, magari richiamandosi a Benjamin e Deleuze convertiti in feticci, per fondare, costruire, edificare, fortificare.
… the “building-block” approach to knowledge so typical of bourgeois social science and deeply ingrained in widelt accepted bourgeois modes of thought. According to this libe of thought, it is possible and desirable to build solid foundations to knowledge by isolating basic components within the social system and subjecting them to detailed investigation. Once the component is understood, we can build upon it as if were a fixed and immutable foundation for subjecting enquiry (David Harvey).
Robert Warshow già negli anni ‘40 stigmatizzava questo riduzionismo dicotomico per cui coloro che si occupano di cinema si focalizzerebbero o sui visual patterns o sulla mass psychology, spesso faticando perfino a connettere l’una e l’altra cosa. Ma perfino Edgar Morin – dopo tutto, un accademico – ha sempre concepito il cinema come un fenomeno multidimensionale, complesso, irriducibile ad un pensiero riduttivo, cioè demarcato e delimitato. Questo tipo di criticismo, che è comune sia all’Accademia che a certo mondo delle gazzette cartacee e digitali, soggioga, per dirla con Manny Farber, la bestialità dell’immagine e del suono, per scomporla e ricomporla, addomesticarla in un sapere disciplinare codificabile e trasmissibile. Per comporla, renderla composta, riducendola ad alcuni elementi facilmente maneggiabili almeno al punto da dimostrare l’abilità del critico accademico o internauta. Recentemente Olivier Assayas, critico e cineasta, ha tuonato contro questa visione riduttiva del cinema, inscritta in un tipico pensiero borghese, ricordando che il cinema è sempre in crisi perché da sempre è correlato a quel capitalismo che, da Marx all’Italian Theory, non solo è sempre in crisi ma funziona attraverso la crisi.
I think there is no other symptom more relevant to an art’s vitality than its constant reappraisal, in accordance with the constant reformulation of our world. The real issue would be to know whether the forces that transform the world are the same forces that transform the arts, how both feed on one another, unless they are contradictory (Assayas).
Filmologia e sociologia sono un po’ come le “libertà negative” di cui parlava Hannah Arendt, quelle che i regimi delle democrazie liberali facilmente concedono, libertà che non fanno paura a nessuno. Ma, come ricorda Arendt, la libertà è potere, potere di partecipazione alla gestione della comunità delle cose comuni. In omaggio al venerando e temibile filmologo, riduco di carattere questa introduzione ma, nondimeno, apro il mio contributo proprio con questa, probabilmente poco aderente alle regole (manie dello spirito direbbe Lucrezio) – che tutto vogliono circoscrivere e inscatolare – ma ispirata, per dirla ancora con Aristotele, da una certa disposizione (attitudine morale, esercizio attivo, scelta del “bene”). A maggior ragione in un’epoca contrassegnata dalla pandemia del COVID-19 che dimostra sempre più l’interconnessione del global commodity chains, per dirla con John Foster Bellamy, in cui si manifestano frequenti zoonosi ed emergono i virus trasmessi in tutto il globo attraverso le connessioni umane, le relazioni e le istituzioni della globalizzazione neoliberista. Il COVID-19 emerge e si sviluppa attraverso i circuiti del capitale, come dimostrano economisti, filosofi, biologi, ecc., basti leggere le recenti analisi di Mike Davis. Ma del cinema no, non si può nemmeno abbozzare che, quantomeno, è un fenomeno da sempre correlato all’industria, ai discorsi che circolano nella società capitalista, ai regimi di visibilità e dicibilità della modernità, ecc. Come il COVID-19 non è un “oggetto” puntuale e isolabile, né tematizzabile solo con le categorie della virologia e della epidemiologia, ma un campo di fattori tra loro connessi, il campo delle relazioni eco-sistemiche determinate dai processi del capitale; così il cinema non è pensabile solo attraverso i discorsi ben delimitati e facilmente trasmissibili nelle aule universitarie ed è sempre raccordato alle chains of global exploitation and expropriation che, fra le altre cose, destabilizzano le relazioni ecologiche ed umane. Il che non equivale a presupporre un discorso teorico su come e quanto il cinema sia un apparato di cattura – anche perché su questo molto è stato già scritto. Pur tenendo nel debito conto che il cinema soggettivi assoggettando, la proposta che segue tende ad accentuare un altro lato, quello per cui è il cinema una linea di fuga.
Nel panorama mediale contemporaneo – contrassegnato da una insensata e sterminata cavalcata ininterrotta di immagini, suoni, selfie – inscritto nelle più ampie forme di vita del capitalismo neoliberista e neo-estrattivista e dell’organizzazione postfordista del lavoro, il cinema sperimenta mutazioni sociali, tecnologiche, metapsicologiche, estetiche e linguistiche. La macchina-cinema è sempre il concatenamento di questa eterogeneità, cioè di tutti questi elementi, come abbiamo già avuto modo di scrivere.
Il cinema da anni ormai è chiamato ad affrontare la crescente concorrenza di altre forme d’intrattenimento dell’industria culturale – che non è più un settore dell’industria, come all’epoca di Horkheimer e Adorno ma, come ha spiegato Paolo Virno, un modello per tutta la produzione sociale sempre più fondata sul General Intellect, quindi sulle virtù dell’affettività, della comunicazione, della cooperazione, ecc. Il cinematic mode of production descritto da Jonathan Beller è ormai diventato il modello dell’attention economy neoliberista. Inoltre il cinema si confronta con quello che è stato chiamato “post-cinema”, cioè con la “portabilità” del film dislocato in una molteplicità di supporti (iPad, iPod, computer, ecc.); tutti fenomeni a loro volta correlati alla dialettica tra processi globali e culture locali. La portabilità del film, nell’organizzazione postfordista del lavoro, corrisponde alla portabilità del lavoro, come ha spiegato quel Jonathan Crary, spesso citato dai film scholars che lo citano al pari di Walter Benjamin, senza essere mai davvero conseguenti. Benjamin negli anni ’30 spiegò come, congiuntamente, il training dell’ambiente audio-visivo della metropoli e quello della catena di montaggio modellassero il sensorio umano. Gli choc urbani e quelli del lavoro salariato fordista avevano il loro analogon nei salti e nelle rotture del montaggio cinematografico. L’attore dinanzi agli screen tests era come se vendicasse l’operaio inchiodato alla catena di montaggio – e forse lo spettatore sprofondato nella poltrona. Certo il cinema, in quanto arte delle masse, è come un pharmakon. Provoca choc soggettivo e collettivo ma, come si chiedeva Deleuze, perché non ha ancora trasformato il mondo? Non l’ha fatto saltare per aria, come diceva Benjamin – che non era un pacifico e addomesticato media scholar ma un intellettuale impegnato in una prassi teorica rivoluzionaria. L’automa spirituale rischia sempre di diventare un fantoccio per le propagande del totalitarismo storico e di quello delle merci che caratterizza le democrazie liberali. Vale anche per la tecnologia. Nella testa dei futuristi italiani, la tecnologia viene esaltata ingenuamente da artisti che negli anni ’20 si impiegheranno nella pubblicità o rifluiranno nel fascismo; per i costruttivisti russi è un operatore che, interagendo con la vita quotidiana, il lavoro e l’arte, modifica, trasforma vita, lavoro e arte e, a sua volta, viene ristrutturata da queste interazioni. Il cinema come choc, il cinema come propaganda. Il cinema vendica le masse, diceva Benjamin; la plasmaticità di Disney, osservava Ejzenstejn, è come se liberasse l’operaio, per un istante, dalla standardizzazione e dalla meccanizzazione del fordismo; le figure senza peso di Disney sembrano trionfare sulla catena, si trasformano continuamente, improvvisamente e sorprendentemente. Ma Ejzenstejn stesso ben sapeva che questa plasmaticità è spettralmente affine a quella della fluidità del denaro: ogni cosa si trasforma nel denaro, così come ogni cosa si trasforma nel disegno animato Disney. È un crinale rischioso, sul quale occorre sapersi cimentare.
Nell’epoca del postfordismo, il training a cui siamo sottoposti è, per dirla con Crary, 24/7 e come ha spiegato l’operaismo italiano non c’è più confine tra lavoro e dopolavoro, lavoro e produzione. Il produttore non è più legato alla catena, anzi il suo lavoro, un po’ come nell’animazione Disney, si configura sempre più come plasmatico, creativo, imprevedibile.
Il pendolare che sul treno guarda un film sul suo smartphone – mentre risponde ad una mail di lavoro e fa l’upgrade di un programma fornendo dati commerciabili – è massaggiato non tanto da questo o quel messaggio, ma da una forma che lo addestra a rispondere, che lo interpella ad essere sempre produttivo, pur nella distrazione e nello svago; a produrre plusvalore, anche quando non lavora, perfino quando si diverte. La portabilità del cinema o del cosiddetto “post-cinema” implica certamente delle mutazioni nel campo della spettatorialità, della fruizione, ecc., che poi è il livello di competenza dei film scholars. Ma per comprendere radicalmente queste mutazioni occorre sapere che esse hanno a che vedere, in ultima analisi, con i pattern flessibili dell’organizzazione postfordista delle forme del lavoro e, ahinoi, delle forme di vita. L’immagine cinematografica fa corpo con questi apparati (ideologici) di cattura del pluslavoro e con queste forme di vita.
***
Secondo Jean Louis Schefer, l’immagine designa ideologicamente il raddoppiamento dello spazio o di una sequenza, come nel cinema. L’immagine è ideologica in quanto rappresentante del significato. Essa appartiene ad una pratica di cui uno degli effetti è riprodurre il reale attraverso un processo sensoriale, quello della visione e infatti molti artisti, da Alberti e da Leonardo, hanno indagato il processo della visione. Si sono interrogati sulle condizioni di possibilità della visione per meglio riprodurre il reale. La matematica, la geometria e le costruzioni di “macchine” per vedere e riprodurre il reale, sono stati i contrassegni delle loro prassi teoriche, ma anche di quelli di altri, come Descartes, autore di una Diottrica. Il “soggetto” (della) visione, quindi, è sempre stato come assoggettato ad una certa “prospettiva”, angolazione, punto di vista, discorso teorico o regime scopico… L’immagine è quel significante determinato nella sua specificità come da un altrove. Per Descartes, in ultima istanza, vedere è pensare e questa riduzione è dovuta ad un determinato gioco linguistico, inscritto nella forma di vita della sua epoca, quella della Rivoluzione scientifica correlata all’affermarsi del capitalismo, della “Grande Divisione” di cui parla Bruno Latour, ecc. Schefer parla di fond idéologique: la visione è sempre l’effetto di una “produzione”. Gli epistemologi del ‘900, nel loro linguaggio spesso così assertivo, direbbero: l’osservazione è carica di teoria. La visione e, dunque, correlativamente, l’immagine, è come il residuo di operazioni che per lo più sono come cancellate o rimosse, operazioni collegate alle istituzioni, alle relazioni umane, sociali, culturali, politiche, alle formazioni discorsive, ecc. Il Gadda della Meditazione milanese direbbe che il “dato” è un complesso di nozioni e funzioni.
Ma les effets de cette disparition de l’appareil du travail hors du champ sémantique de l’image lasciano tracce, questo lavoro fuori campo, in breve, è ciò che istituisce quel reticolo concettuale e esperienziale che chiamiamo: trasparenza cinematografica, situazione cinematografica, impressione di realtà, ecc., insomma tutto ciò che fa funzionare la macchina-cinema al livello del rapporto tra spettatore e schermo. L’immagine è effetto di una écriture, che non è solo quella del macchinismo cinematografico, del gioco, del relais, anzi, dell’agencement “tra” discorso e autore; ma anche quello dei discorsi teorici, della critica, per esempio della semiologia che ha quasi sempre ridotto la figurazione alle leggi del linguaggio scritto e/o parlato – come riconobbe anche lo stesso Metz. La critica che Schefer – allievo di Barthes – fa alla semiologia anticipa quella di Deleuze. Come ha scritto Paolo Fabbri, la prima semiologia barthesiana era modellata sulla lingua e, dopo tutto, anche il movimento del segno di Eco è riferibile ancora ad un quadro testuale. Ma penser la figuration dans la lettre non è un torto “regionale” della semiologia del cinema, bensì un movimento vasto che investe la globalità dell’Occidente. Anche se, a sua volta, la scrittura alfabetica – come dimostrato, fra gli altri, da Ong e Havelock, Derrida e Sini – ha istituito il privilegio, se non il dominio del senso della vista. Ma l’immagine (cinematografica) non è mai riducibile al solo organo di senso della vista. Come scrive Gadda nella Meditazione milanese, l’occhio non ha il monopolio nemmeno sui fenomeni luminosi, poiché anche la pelle (dello spettatore) risente o avverte gli effetti luminosi… L’organo di senso lavora a più mestieri e il cinema è quel laboratorio in cui meglio o più radicalmente si osserva e sperimenta questo aggrovigliarsi di sensi. Dopo tutto, anche l’espressione “audio-visione” non restituisce radicalmente la complessità multisensoriale del cinema. Ejzenstejn, in polemica con il cine-occhio vertoviano, sapeva bene che il cinema non è solo occhio o sguardo, ma un dispositivo postmediale. In quanto potenza e potere formatore, il cinema è un medium, ma non è un medium “caldo”, come credeva McLuhan, ma “freddo”, cioè non privilegia un senso (la vista) ma è plurisensoriale (mette in gioco l’udito, il tatto, a volte perfino l’olfatto). Arnheim, in ultima analisi, rigettava il cinema proprio perché le sue forme non erano desunte da un solo medium; una concezione tipicamente modernista, almeno nell’accezione paradigmatica datane da Clement Greenberg.
Per Ejzenstejn il cinema è un’attrazione di media e proprio per questo è capace, come un trattore, di penetrare, anzi arare tutto il sensorio umano, più di un quadro, un libro o uno spettacolo teatrale. Ejzenstejn ne La natura non indifferente parla di “postpittura” , “premusica”, “musica per gli occhi”, “poesia del disegno” e “pronuncia plastica”. Il cinema può prendere a pugni, far balzare dalla poltrona lo spettatore, quella nella quale qualcuno vorrebbe farci sprofondare comodamente – magari mentre rispondiamo all’interpellazione postfordista, leggendo e inviando mail di lavoro, scaricando un programma, fornendo dati, ecc.
L’immagine ha un sens investi: investe di sé ciò che si chiama reale – rendendolo visibile – ma è a sua volta investita da questo lavoro fuori campo – che è come invisibile. Insomma, ancora una volta, a dispetto dell’anatema del famoso filmologo laureato, anche Schefer pone la questione del politico, osservando che la significazione dell’immagine è una produzione nel senso di Freud – Kuntzel pochissimi anni dopo avrebbe tematizzato questo motivo del travail du film – e anche nel senso di Marx, in quanto economia. La critica cinematografica si configura come una critica dell’economia politica dell’audio-visione – almeno per coloro che non sono incantati-incatenati nello spettacolo dei convegni accademici e delle logistiche di potere o nella ricerca del Sacro Gral della grafica friendly per catturare like e sottoscrizioni.
Schefer è interessato, più che alla delimitazione di campo, ai sistemi e ai processi di significazione, per dirla con Fabbri che, su questo punto, è più prossimo a Schefer che non a Eco. Infatti Schefer – impiegando provocatoriamente una sempre equivoca ma famosa espressione – a conferma del nexus, dell’articolazione tra produzione e significazione, ricorda che il “modo di produzione asiatico” ha prodotto immagini che non sono come quelle occidentali. Nelle immagini dell’Asia c’è una sparizione del referente. Così si spiega perché la scrittura geroglifica degli Egizi, per Freud, in quanto non grammaticale, era più affine alla “lingua” dell’inconscio irriducibile alla grammatica della scrittura alfabetica che atomizza e linearizza. L’origine dell’immagine – anche di quella cinematografica – è sempre un fable: comunque se ne discorre, corre nei discorsi, nelle parole. Quantomeno l’immagine è il nome di un’unità che è sia percettiva che semantica ma, soprattutto, è una funzione nell’economia della rappresentazione.
***
A dispetto del tabù accademico, videogame, Imax, 3D, digitale, post-continuty, ecc., sono tutti temi che raccordano motivi sociali, psicologici e linguistici, cioè la critica cinematografica, come sostenuto ampiamente in altre occasioni, non può che essere anche critica dell’economia politica dell’audio-visione e della rappresentazione.
Studi accademici, da molti anni ormai, hanno rilevato che il cinema ha vissuto passaggi e trasformazioni: dall’ottico ad altri sensi. Cinema dell’accesso e del’ibridazione. Vero. Ma, in fondo, il primato dell’ottico era stato già contestato da Duchamp e dal Dada, dal Costruttivismo russo e più tardi dall’Arte Concettuale e dalla Body Art. Si enfatizza inoltre la logica dell’accesso. Certo l’età dell’accesso non significa accesso comune alle risorse che sono comuni, ai dati e alle informazioni, né, quindi, accesso alle occasioni del mondo. La retorica sull’età dell’accesso va rettificata realisticamente, raccordandola con le operazioni algoritmiche che canalizzano quelli che appaiono flussi aleatori e che invece privatizzano ciò che è frutto di cooperazione e condivisione. L’accesso è una delle tante categorie del pensiero allegro e disinvolto, che si converte presto in una facile formula da manuale. Quanto all’ibridazione, questa va intesa radicalmente e non strumentalmente o sociologicamente, ovvero come un processo di translation, sulla scorta di Benjamin, Said e Bhabha, cioè come un dia-logo che nella distanza tiene sempre aperta l’istanza del faccia a faccia. Il cinema, così, può essere considerato aptico, aperto e ibrido.
Il cinema tende a diventare multimediale e per quanto può interattivo. Per esempio, il film non finisce ma continua nel video-game. La sala non è più l’unico luogo in cui consumare, fruire e vedere un film e le modalità di consumo, fruizione e visione plasmano il rapporto tra il soggetto e l’oggetto, tra chi vede e il film visto – quando è un film: il film è la pellicola. Si vedono i film in piena luce e sollecitati da altri stimoli provenienti dagli ambienti circostanti, non nell’oscurità della sala, spesso da soli e non in compagnia di altre persone come succede nel cinema. Negli anni ’30 Benjamin osservava che nell’istituzione cinematografica la ricezione si inscrive nella distrazione e la distrazione a sua volta smonta la lontananza dell’aura che separa la massa dalle opere d’arte. Ma in questo caso la ricezione nella distrazione è un fenomeno ancora collettivo, nelle nuove forme di consumo invece è solo individuale. e la distrazione è aumentata a livello esponenziale.
Sono motivi tecnologici, estetici e di ricezione, che legano lo sguardo al dispositivo riconfigurando l’esperienza spettatoriale. Benjamin sottolineava la differenza tra il contemplare una statua di Venere nel contesto natio e vivente, nel culto dei greci, rispetto al contesto medievale dei monaci che vedevano nella statua un idolo da maledire. All’inizio del terzo paragrafo di L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Benjamin scrive che nel lungo periodo, non solo i modi generali di esistenza delle collettività umane si modificano, ma anche i modi e i generi della loro percezione sensoriale, il loro medium, cioè il modo in cui si organizza la percezione che è sia naturale sia storica. E molto prima ancora, Platone demarcava la differenza tra parola scritta e parola parlata. La questione dei “supporti” è antica e risale, per l’appunto, almeno alla Settima Lettera. Motivi su cui abbiamo già avuto modo di scrivere.
TEMPO, SPAZIO E MOVIMENTO
Il cinema non è negoziazione né pacifica rilocazione, ma riorientamento e sconvolgimento dei dualismi logocentrici – incluso quello tra figurativo e astratto; fa saltar per aria il mondo così come l’abbiamo conosciuto. Produce choc; altrimenti il cinema è solo un pretesto per organizzare convegni, non muovendo mai un dito per trasformare il reale; al più è solo una semplice possibilità logica. Arte delle masse, soggettiva e collettiva, che fa vibrare. Lo ricorda Gilles Deleuze, dopo Benjamin e Ejzenstejn. Ma Deleuze, Benjamin, Ejzenstejn non sono note a pie’ di pagina ma operatori di cambiamento. Il cinema è onda nervosa, fa nascere il pensiero. Deleuze cita Artaud. Altro che home theatre e negoziazione. Il cinema forza a pensare, sospende il mondo così come lo conosciamo, disturba, scuote. Mostra l’intollerabile e crede ancora nel mondo: Roberto Rossellini.
Cent’anni fa Jean Epstein scriveva che abbiamo un doppio sistema di conoscenza: razionale e affettivo. La luce è un fenomeno elettromagnetico ma anche un fenomeno di poesia. Il cinema trascende il dualismo che caratterizza il logocentrismo: è lirosofia. È conoscenza simultaneamente razionale e affettiva. L’immagine dell’universo conosciuta è quella creata: anche se riproduce, imita, il cinema attraverso la successione e la discontinuità deforma il tempo e lo spazio. Negli anni in cui nasceva il cinema, Edmund Husserl diceva che la coscienza è sempre coscienza di qualcosa. Il cinema, per dirla con Gaston Bachelard, rende alla ragione la sua funzione di turbolenza e aggressività. Il cinema è l’esuberanza del logos. Una macchina intelligente – come mostrano i film di Andy Warhol o La Région centrale (1971) di Michael Snow – che sconvolge le gerarchie e il pensiero oppositivo occidentale. Epstein scrive: scienza emozionata. Il cinema, per Epstein, è un’estetica al quadrato. Estetica della prossimità, della suggestione, della successione, della rapidità mentale, della sensualità, delle metafore, momentanea. È dettaglio; allude e indica e non si limita a raccontare, invitando lo spettatore ad esercitare la sua libertà costruttiva (poco nel cinema classico, secondo Béla Balázs; molto nel cinema moderno, secondo André Bazin); è mobilità come la vita tutta; velocità di pensiero, choc, innesco rapido del pensiero; il materialismo sensuale della pellicola depenna qualunque idealismo, il cinema è corpo; il volto del primo piano è in carne e ossa, mi impressiona a differenza dell’essenza del volto che è solo un fantasma; è poesia, una cavalcata di metafore, sovrimpressioni e dissolvenze sono i mezzi che il cinema impiega senza scadere mai nel simbolismo; è l’arte del transitorio, modernissima, non dura, come le immagini che scorrono e si trasformano attraverso il montaggio e l’illuminazione. Il cinema è instabile, una metamorfosi incessante, mobilità nel tempo e nello spazio, un attentato all’ordine, soprattutto quando il cinema accelera o rallenta, quando produce o innesca un movimento aberrante, come direbbe Gilles Deleuze. L’immagine-movimento è duplice: tra gli oggetti – che variano fra loro – ed è anche il tutto espresso dal cambiamento. Ma il movimento è anche aberrante, sottratto alla centratura, anomalo. Ralenti e cambiamenti continui di scala e proporzione, scrive Deleuze, testimoniano ancor di più che il cinema, come voleva Epstein, non si limita mai a riprodurre un mondo ma lo costituisce. Percipiente e percepito hanno perduto i loro punti di gravità, non sono più assoluti ma relativi. Immobilità e eccesso di movimento, per Jean-François Lyotard, sono intensità che assaltano la tirannia di ordini che si impone mediante l’impressione di realtà. Nel ralenti e nell’accelerazione violenta il cinema rompe con il movimento sterile del reddito che lega il pulsionale, equilibrando, canalizzando, veicolando attraverso l’imposizione di una buona forma. La buona forma che addomestica, anzi linearizza il libidinale. Leggendo Lyotard – che fa i nomi dei pionieri del film astratto Eggeling e Richter, ma anche quello di Baruchello – si può pensare che questo movimento pirotecnico sia proprio di quel cinema che mette le mani perverse nel supporto, insomma il film sperimentale di Brakhage o Frampton. Questo movimento aberrante è mobilità che scuote la pelle dello spettatore. Disfarsi attraverso la mobilità o l’immobilità delle belle forme, vuol dire far esultare il corpo dello spettatore. L’ecclesia del film organico salta per aria, nell’esibizione scoperta e oscena del funzionamento del suo dispositivo – non solo nel film strutturale ma anche in Godard. Insomma questa mobilità che, brechtianamente, decostruisce cancellature e operazioni che rendono il film trasparente e che scatena processi primari, sarebbe tipica di un certo cinema sperimentale o comunque moderno. Deleuze osserva che questo certo è un tratto del cinema moderno, che lo distingue da quello classico. Ma le aberrazioni del movimento sono antiche quanto il cinema, solo che, osserva Deleuze, sono state come compensate, legate, se non sublimate dalle leggi della buona forma; dalle leggi della grande forma e della piccola forma del cinema classico, come dice Deleuze. C’è variazione continua già in Vertov. E, in fondo, la dialettica organicità-pathos teorizzata da Ejzenstejn poneva già la questione alquanto precisasmente: il film può essere organizzato, articolato ordinatamente ma, al tempo stesso, essere spezzato da una cesura. La sezione aurea del film è contrassegnata, anzi contrappuntata da segni che introducono pause e accelerazioni.

La Région centrale (1971)
Tempo e spazio, sia nel film organico che in quello sperimentale e/o moderno, si compongono di rapporti e variabili. Il cinema è uno spazio-tempo in cui lo spettatore osserva i fenomeni del dilatarsi e contrarsi. Spazio e tempo, ha scritto Amengual, nel cinema sono, insieme, astratti e concreti, presenza e evocazione. Anche il film più lineare non è mai cronologico e il film più realistico non è mai semplicemente riproduttivo. Barthes ha spiegato come il realismo sia una convenzione stilistica. Arnheim e Ejzenstejn avevano concezioni divergenti, se non opposte attorno al film – per il primo deve essere, nel segno del Modernismo, “puro”; per il secondo è postmediale, multisensoriale – ma per entrambi il film non è realistico. Il cineasta, inoltre, osserva che il realismo è sempre composizione; mentre il teorico distingue tra “immagine reale” e “immagine filmica”, poiché la fotografia – a dispetto dell’anatema estetista di Baudelaire – è “irreale”. King Vidor scriveva che tra illusion e reality, moving–picture e natural world non c’è corrispondenza ma gioco, scarto, dislivello: nel primo non c’è movimento, nel secondo sì. Truth and Illusion (1964) di Vidor, prima ancora delle analisi di Baudry o Comolli o dei film strutturali di Hollis Frampton o Morgan Fisher, è anche un’introduzione alla metafisica del cinema, mostra proprio il suo funzionamento: l’illusione del movimento.
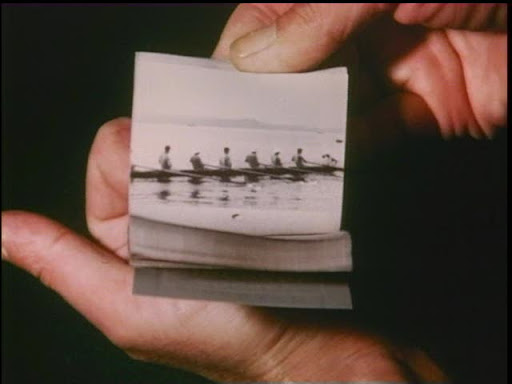
Truth and Illusion (1964)
Lawrence Alloway: «all realist styles of art, literaly or visual, are mediated by conventions, formal structures that lead from the outward display of the content». Come diceva Balázs: l’inquadratura dà forma, non riproduce ma produce le immagini; e il taglio, cioè il montaggio, rende ancora più creativo e costruttivo il film, creando ritmo figurativo e narrativo, disarticolando e riarticolando spazio e tempo. Barthes l’aveva già detto che il realismo è un codice, Schefer, connotando l’immagine, scrive che il suo statuto “reale” non si articola su un referente “là fuori”, “là davanti”, ma si artiglia sul codifiant probable o sul più probabile. Non c’è un contenuto da mostrare o raddoppiare, ma un processo per cui si istituisce una struttura, un’immagine. Perfino per quel Platone che condanna le arti, la mimesis non è mai semplice imitazione – concetto che ha luogo a cominciare da Democrito – non è mera rappresentazione di qualcosa ma, come scrive Remo Bodei, la «capacità di esibire la rappresentazione di qualcosa in modo che essa sia presente, rappresentata appunto». In questa luce il film strutturale di Snow, Sharits, Frampton, Kubelka e altri, appare come la quintaessenza del cinema, il cinema al quadrato, metacinema che espone se stesso e le sue stesse condizioni di esistenza. Oltre l’hybris antropocentrica che immagina, riduce e forza l’oggetto, la non-identità adorniana in una rappresentazione, che non lascia margini di possibilità, riserve, adombramenti, misteri – e oltre, ovviamente, realismi ingenui e sensi comuni – il cinema, narrativo o sperimentale, sempre allude. A volte nel cinema questa allusione infatti è manifesta, come sottolineata, per esempio nei virtuosismi e nelle deformazioni della fotogenia francese e dell’espressionismo tedesco. Nella Repubblica Platone parlando dell’arte la riferisce agli specchi, ma gli specchi possono essere rotondi e deformanti. Ma anche la trasparenza hollywoodiana non è che allusione, risultato composito di un’operazione a più livelli, che mobilita una molteplicità di elementi. Semmai, sempre per citare il Platone della Repubblica il film classico hollywoodiano appare come gioco, mentre il film strutturale come qualcosa di serio.

Adebar (1957)
Mimare il visibile e l’udibile non è mai riprodurlo; è, per continuare con i greci, danza delle stelle e, osserva Bodei, l’espressività della danza risiede nel numero, anzi nel rapporto tra numero e cosa, cioè nel ritmo. Se è così – per quanto paradossale – allora cinema puro non è solo quello di Hans Richter, Ernie Gehr o Peter Kubelka, ma anche il famoso incipit di un film di David Lynch o il ritmo incalzante di Raoul Walsh, i cui film, a volte, sono pura forma del narrato, dispositivo ritmico che costruisce movimenti narrativi e traiettorie di corpi. I film di Walsh sono anch’essi paradigmatici del cinema o del suo funzionamento. Non importa tanto ciò che contiene, la storia raccontata – che spesso è una variazione di schemi che si ripetono – ma la trasformazione, la forma del transito che è anche trasformazione continua della forma. Raymond Bellour ha scritto che la mobilità del film è irriducibile al linguaggio, al logicismo semiologico.

Mulholland Drive (2001)
Nel film spazio e tempo, ambienti e personaggi, mostrazione e narrazione, per dirla con Gaudreault (anche se già Bazin scriveva che il cinema è montrer e dire, reproduire e raconter), sono relativi gli uni agli altri e percepiti da una durata che, come dice Whitehead, il presente d’osservazione, l’evento percipiente, lo spettatore. Il film è in relazione, nella relazione con l’evento percipiente, c’è una cogredienza tra il corpo dello spettatore e quello del film, che non è mai compatto ma si modifica in questa corrente d’esperienza, nel campo fisico in cui spettatore e film sono dis-giunti. Nel 1916 Hugo Münsterberg osservava che il cinema, a differenza del teatro, lo spazio si forma nella mente dello spettatore. Gli avvenimenti cinematografici hanno una spazialità tridimensionale e reale, sono profondi, ma nella mente dello spettatore lo spazio si presenta, appare bidimensionale, piatto. La mente dello spettatore trasforma questa flatness in figure plastiche. Le immagini sono sezioni immobili del movimento – dell’eternità – eppure, scrive Münsterberg, noi percepiamo immagini in movimento, perché è la mente dello spettatore a collegare le immagini. È una nostra immagine mentale.
Balázs, citando Marx, scriveva che la realtà in sé è l’esperienza umana, che la realtà è oggettiva e anche indipendente dal soggetto, ma che per diventare esperienza vissuta, esige che esista un soggetto. Così come la bella musica esiste per l’orecchio che la intende. Balázs, cent’anni fa, insisteva già sul fatto che l’immagine oltre che visibile, è leggibile, insomma richiede una certa messa a fuoco: occorre imparare a vedere – e ad ascoltare.
SCANSIONE RITMICA DELL’ETERNITA’ E PASSING THOUGHT
Lo spettatore è in presenza di immagini, come nell’esperimento che apre il primo capitolo di Materia e memoria di Bergson, pubblicato l’anno dopo l’invenzione del cinema. Emerge la società di massa, la metropoli con i suoi boulevard in cui si inscrive la fantasmagoria della merce. Benjamin ha descritto il training senso-motorio che, attraverso l’inconscio ottico della metropoli e del cinema, modella il corpo del soggetto-spettatore, facendo emergere un sentire artificiale che trasforma la nozione e l’esperienza della realtà. Nella società dello spettacolo, nella consumer society e nel capitalismo 24/7, siamo ancor di più inchiodati nella posizione di spettatori. La critica cinematografica si configura sin dall’inizio come una critica dell’economia politica dell’audio-visione. Bergson, invitandoci a fare l’esperimento di non conoscere niente, scriveva che dappertutto ci sono immagini. Immagini che agiscono e reagiscono le une sulle altre: è la società di massa nervosa, la metropoli degli choc, è il cinema – indissolubilmente intrecciato alla città moderna. Nel cinema, come ha scritto, Edgar Morin, tutto il reale è percepito attraverso l’immagine. Ma fra le immagini, scriveva Bergson, ce n’è una che stacca dallo sfondo: è il mio corpo, l’immagine mentale di Münsterberg – il cervello fa parte del mondo materiale, è un’immagine come le altre. Cogliamo le cose come immagini. Il cinema è come il laboratorio in cui possiamo esperire ogni volta l’esperimento bergsoniano. La presentness descritta da Cavell, infatti, non è tanto la convinzione che ci sia un mondo presente a noi ma our presence to it. La presence of self cavelliana fa risonanza con il corpo bergsoniano e l’immagine mentale di Münsterberg. Presenza a sé, direbbe Merleau-Ponty, è presenza a un mondo. Il cinema è un esperimento ontologico, un’ontogenesi perpetua.
La percezione è il taglio di bisturi operato in questo sistema di immagini che è il mondo. La rappresentazione non è una diminuzione della presenza. L’immagine è virtuale ma, al tempo stesso, “è là”. La cosa del mondo diventa immagine quando non è mai semplicemente incastrata nel contesto, nello sfondo, ma quando si staglia e diventa un quadro. Questa immagine che siamo noi è il luogo di risonanza, scrive Jean Louis Schefer, delle immagini e dei suoni, la significazione si fa sensibile quando il senso giunge a noi. Schefer scrive che lo spettatore viene come gettato fuori di se stesso attraverso lo specchio del film. Esco fuori di me stesso entrando nel film e questo, così visibile, giunge al suo senso nella mia camera invisibile.
Bergson anticipa Jean-Luc Godard. Merleau-Ponty direbbe che il quale, la pellicola d’essere, richiede una messa a fuoco. In fondo, è la fotogenia di Louis Delluc, l’aspetto poetico, atmosferico, particolare delle cose. Secondo Epstein, la fotogenia è quella qualità che accresce gli esseri riprodotti dal cinema, una realtà aumentata. Come scriveva Morin, il cinema è scoperta di un mondo sconosciuto e visione del mondo conosciuto. La fotogenia, per dirla con Morin, è il fascino dell’immagine del reale. È l’esistenza atmosferica della pellicola d’essere. Il quale, il mondo “là fuori” non è un lembo d’essere assolutamente duro, scrive Merleau-Ponty, ma è come un talismano estratto dal fondo dei mondi immaginari. Il cinema è proprio questa esegesi ispirata: interroga il mondo ma secondo i suoi voti. La pellicola del visibile, parafrasando sempre Merleau-Ponty, la profondità dell’essere, fa corpo con la carne della visione, la “mia” e quella “macchinica”, perché sia il mio corpo che la macchina da presa sono inscritti e inseriti nello spettacolo del visibile. Anche se, come mostra Blow Up (1966) di Michelangelo Antonioni, c’è differenza tra l’occhio umano e l’occhio della macchina – differenza non è separazione. Il realismo di Rossellini è ontologico: sguardo che vede perché preso nel visibile, come nella teoria aristotelica della sensibilità. C’è intimacy tra visione e visibile.
***
C’è anche dell’idealismo, del platonismo nel cinema? C’è del corpo, come scriveva Bergson. Datemi dunque un corpo! Pensare è apprendere quel che può un corpo, scrive Deleuze. Il cinema è il rovesciamento della filosofia oppositiva istituita proprio da Platone. Il mondo si dà nel suo corpo. Balázs scriveva che la macchina del cinema fa sì che lo spirito si faccia corpo, è linguaggio di gesti e comportamenti, lingua universale perché la parola all’inizio è gesto, come dimostrato dal pragmatista Mead, prima di Derrida; la parola è movimento, come dice Ejzenstejn. Semmai il platonismo ispira il cinema ma diversamente. Cinema è cinematica: c’è della dinamica associativa, il pensiero è questo dinamica, questo choc, ecco perché – almeno all’inizio destava stupore. Il cinema è transito fra le immagini, come nell’associazionismo di Freud o nella libera associazione di Einstein, cioè è pensiero. Platone, nota Giacomo Marramao, pensava il numero in quanto ritmo, cioè transito, come Ejzenstejn. Griffith e Hans Richter sarebbero stati d’accordo nel qualificare il cinema come ritmo. Il cinema è scansione ritmica dell’eternità. L’eterno si rapprende nel transito tra i fotogrammi. Le sezioni immobili dell’aión sono i fotogrammi, incomprensibili senza quello ma anche l’eternità non si può dare che nel concatenamento impercettibile e cronologico di questi. L’inquadratura e il montaggio: Ejzenstejn. Il cinema è mobile ed eterno.
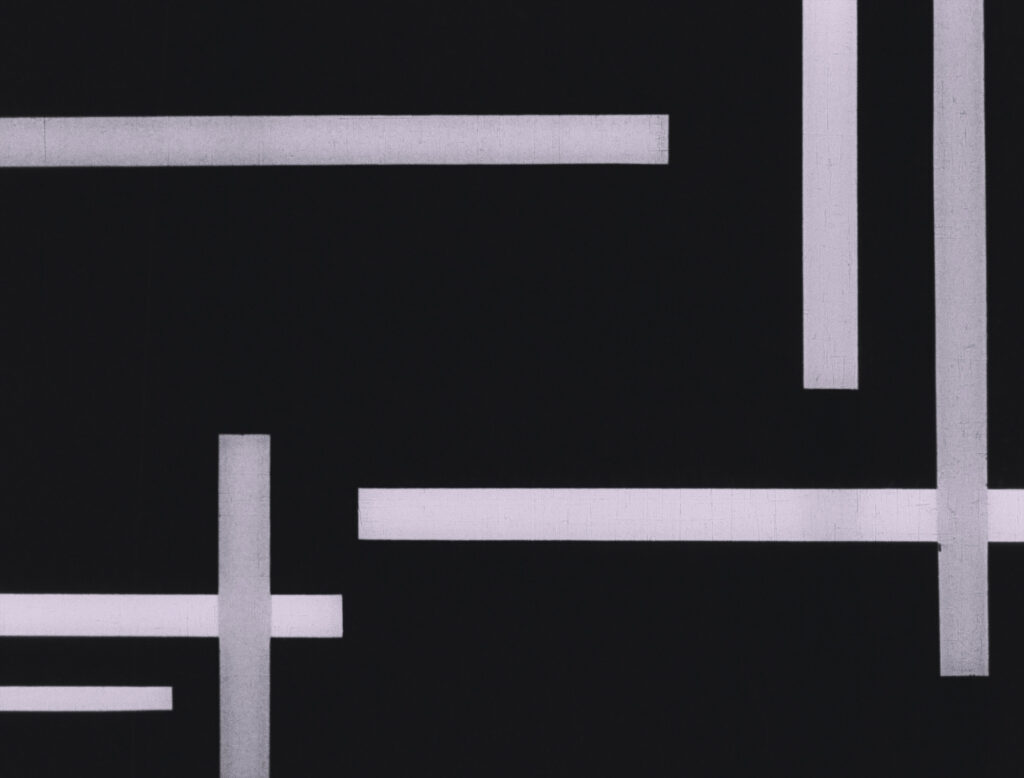
Rhythmus 21 (1921)
Il cinema, per dirla con William James, è passing thought, il passare da un puro a una coscienza, un passare che è con-costitutivo di “puro” e “coscienza”, che è l’esperienza medesima. Il cinema è esperienza, nel senso di James, per cui l’esperienza è transizione e processo, onda, anche se non avvertiamo mai un contrasto nel passaggio da una transizione all’altra. Perché lo spettatore non se ne accorge? Non solo per motivi psicologici e ottici. È le travail du film descritto analiticamente da Thierry Kuntzel. Il lavoro filmico fa sì che lo spettatore fruisca il film, goda del film come uno spettacolo che fluisce, continua, ma il film piuttosto che trasparente è un nodo di significanti, una catena di significanti. Condizione necessaria della continuità è la frammentazione delle inquadrature, la trasparenza narrativa implica l’opacità del montaggio, dei tagli, delle elisioni, delle cancellature, ecc. La continuità classica nel film moderno è, al tempo stesso, confermata e ampliata, soprattutto perché il film moderno insiste, quasi esibisce il lavoro filmico.
Perché il film è anche struttura, matrice, intersezione e il cinema, come sapeva bene Epstein, è industria. Industry, machine and text, scriveva il barthesiano Stephen Heath alla fine degli anni ’70. Il testo filmico è un prodotto industriale, la cui articolazione implica pratiche e processi, creatività e macchinismo. La sua stessa visione è macchinina. Per Vertov il cinema è analisi e sintesi, associazione e dissociazione, smontaggio e montaggio di spazio e tempo. Non solo. Il cine-occhio vertoviano, ancor prima della barthesiana morte dell’autore e perfino della morte dell’uomo di Foucault, disloca il soggetto stesso, lo trasforma, facendo fuoriuscire il soggetto dai suoi stessi cardini. Per Vertov l’occhio meccanico si libera dalla tirannia dell’occhio umano. Parallelamente alla decostruzione del mito romantico e borghese del genio proprietario dell’opera d’arte e del primato retinico, operata da Duchamp e dai costruttivisti russi. Il cine-occhio è più perfetto, esplora meglio e più dell’occhio umano ciò che accade. Largo alla macchina! Prima ancora di Deleuze e Donna Haraway, Vertov non solo propone un programma di ricerca che liberi il cinema dall’occhio e dalla mano – come osserveranno più tardi Benjamin e Stanley Cavell – ma anche un divenire macchinino dell’umano. La cine-percezione del mondo annuncia l’esigenza di oltrepassare l’umanismo e il soggetto nella versione cartesiana, moderna e antropocentrica. Il pensiero della macchina da presa non è positivista, induttivista, verificazionista, logico e lineare, ma scompone e ricompone. Non si tratta mai di imitare o riprodurre, ma di sondare il caos dei movimenti. Il cinema insegna a pensare, risveglia la capacità di pensiero anche in quel soggetto incagliato nelle trappole antropocentriche del pensiero oppositivo e abitudinario. Incontrando il cinema, a contatto con lo choc del pensiero macchinico, anche il pensiero di quel soggetto innesca processi di scomposizione e ricomposizione, si fa montaggio. L’oltreuomo nicciano e l’uomo nuovo dell’Ottobre sono convocati dal cine-occhio vertoviano. L’uomo diventa macchina e si libera, si mette in movimento, a piena velocità, nella folla di quella metropoli in cui emerge il cinema. Il cine-occhio, come la monade leibniziana, riflette tutto il mondo e i suoi movimenti e, attraverso il montaggio, il cinema opera quella combinatoria che Leibniz ha sognato tutta la vita. Nel Kinoglaz ciò che (io-macchina) vedo è montato, ciò che è visto è come se fosse visto per la prima volta: Kinoglaz e Kinok-montatore
Il film è costruzione, costruttivismo. Il testo filmico, scrive Heath, è l’intersezione di industria, narrazione e macchina. È attraverso l’organizzazione narrativa dello sguardo che il film prende senso e che lo spettatore si lega al film come spettacolo e mondo. Il film è costruzione, processo di costruzione che Heath – e Jean-Pierre Oudart prima di lui – chiama sutura, un reticolo di movimenti, tagli, intermittenze, assenze, ecc. Come la pallina da tennis del finale di Blow Up, incessantemente assente, mancante, ma, insieme, continuamente recaptured, per dirla con Heath, messa in forma nella sua assenza, di cui lo schermo restituisce una traccia. Cavell scriveva: we see things that are not present; questo feeling ci fa riscoprire il mistero dimenticato delle cose, nella vita quotidiana date per scontate. La traccia, non tanto, o non solo, quella di Jacques Derrida, ma quella di cui parla all’inizio del suo libro Schefer: il potere di persistenza delle immagini (e dei suoni) è dato insieme, paradossalmente e indissolubilmente, al movimento di sparizione delle immagini (e dei suoni). Ciò che vediamo e udiamo è “là” sullo schermo, proiettato – e la proiezione implica una situazione cinematografica, condizione psico-sociale; ma ciò che vediamo e udiamo non è là, ciò che è presente è assente. E, insieme, ciò che è assente, il volto di Lillian Gish o Liv Ullman, è presente. Il realismo cinematografico, ha scritto Amengual citando Lacan, esalta la presenza esasperando l’assenza. «Il cinema ci affida il mondo con lo stesso movimento con cui ce lo rifiuta» (Amengual). È il suo erotismo. Toccare il volto, far sentire la pellicola, la texture materiale della visione innesca sempre una tensione che cortocircuita la trasparenza del film. Nel 1970 Schefer scriveva: L’image est la persistance de ce qui a disparu.
(Continua…)
Toni D’Angela
Bibliografia (parziale)
Theodor W. Adorno, Parva aesthetica. Saggi 1958-1967
Giorgio Agamben, L’aperto. L’uomo e l’animale
Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo?
Lawrence Alloway, Violent America: the Movies 1946-1964
Barthélemy Amengual, Per capire il film
Hannah Arendt, Vita activa
Guido Aristarco, Storia delle teoriche del film
Aristotele, Etica Nicomachea
Rudolf Arnheim, “Immagine reale e immagine filmica”, in Guido Aristarco (a cura di), L’arte del film. Antologia storico-critica
Olivier Assayas, “State of Cinema”, Sebzian, https://www.sabzian.be/text/state-of-cinema-2020
Gaston Bachelard, L’impegno razionalista
Gaston Bachelard, Poetica dello spazio
Béla Balázs, Il film. Evoluzione ed essenza di un’arte nuova
Roland Barthes, Sul cinema
Jean-Louis Baudry,“Ideological Effects of the Basic Cinematographic Apparatus”, in Philip Rosen (a cura di), Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader,
André Bazin, Che cos’è il cinema?
André Bazin, Le cinema de la cruaté
John Foster Bellamy and Intan Suwandi, “COVID-19 and Catastrophe Capitalism”, Monthly Review
Jonathan Beller, Cinematic Mode of Production
Raymond Bellour, L’analisi del film
Raymond Bellour, La querelle des dispositifs
Walter Benjamin, Hashish
Walter Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica
Walter Benjamin, I “passages” di Parigi
Jane Bennett, Vibrant Matter. A Political Ecology of Things
Henri Bergson, Materia e memoria
Maurice Blanchot, L’infinito intrattenimento
Remo Bodei, Le forme del bello
Benjamin H.D. Buchloh, “Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art”, in Benjamin H.D. Buchloh, Fomalism and Historicity
Noël Burch, Il lucernario dell’infinito. Nascita del linguaggio cinematografico
Francesco Casetti, “Back to the Motherland: the Film Theatre in the Postmedia”, in Sceen
Francesco Casetti, Galassa Lumière
Stanley Cavell, The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film
Jean-Louis Comolli, “Technique and Ideology: Camera, Perspective, Depth of Field [Parts 3 and 4]”, in Philip Rosen (a cura di), Narrative, Apparatus, Ideology
Jonathan Crary, 24/7
Gilles Deleuze, L’immagine-movimento. Cinema 1
Gilles Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema 2
Gilles Deleuze, “Che cos’è un dispositivo?”, in Gilles Deleuze, Divenire molteplice
Gilles Deleuze, Immanenza, Mimesis, Milano 2010
Jacques Derrida, “Prefazione” a Antonin Artaud, Il teatro e il suo doppio
Jacques Derrida, Pensare al non vedere. Scritti sulle arti del visibile
Jean Epstein, L’essenza del cinema
Albert Einstein, Come io vedo il mondo
Sergej M. Ejzenstejn, La natura non indifferente
Sergej M. Ejzenstejn, La forma cinematografica,
Paolo Fabbri, La svolta semiotica
Manny Farber, Negative Space
Dino Formaggio, Problemi di estetica
Hal Foster, Il ritorno del reale
Michel Foucault, Follia e psichiatria. Detti e scritti (1957-1984)
Michel Foucault, La vita degli uomini infami
Carlo Emilio Gadda, Meditazione milanese, in Carlo Emilio Gadda, Scritti vari e postumii
André Gaudreault, Dal letterario al filmico. Sistema del racconto
David Harvey, The Limits of Capital
William James, Saggi sull’empirismo radicale
Fredric Jameson, Il postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo
Michael Hardt-Toni Negri, Impero
Stephen Heath, Questions of Cinema
Martin Heidegger, I concetti fondamentali della metafisica
Rosalind Krauss, L’arte nell’era postmediale
Rosalind Krauss, Reiventare il medium
Thierry Kuntzel, “Le travail du film”, Communications
Henri Lefebvre, Critica della vita quotidiana
Jurij M. Lotman, Semiotica del cinema
Jean-François Lyotard,“L’acinema”,in A partire da Marx e Freud
Christian Marazzi,The Violence of Financial Capitalism
Giacomo Marramao, Kairós. Apologia del tempo debito
Karl Marx, Il capitale, Libro I
Maurice Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile
Christian Metz, Semiologia del cinema
Christian Metz, Cinema e psicanalisi
Edgar Morin, Il cinema o l’uomo immaginario
Laura Mulvey, Cinema e piacere visivo
Hugo Münsterberg, Film. Il cinema muto nel 1916
Jean-Pierre Oudart, “La suture”, Cahiers du Cinéma,
Jean-Pierre Oudart , “La suture. II”,Cahiers du cinéma
Jean-Pierre Oudart, “L’effet de réel”,Cahiers du cinéma
Vsevolod Pudovkin, “Il montaggio”, in Guido Aristarco (a cura di), L’arte del film
Jean Louis Schefer, “L’image: le sens investi”, Communications
Jean Louis Schefer, L’uomo comune del cinema
Girish Shambu, The New Cinephilia
Michael Snow, “Letter from Michael Snow to Peter Gidal on the film Back and Forth”, in Peter Gidal (a cura di), Structural Film Anthology
Jurij Tynjanov, Avanguardia e tradizione
Jakob von Uexküll, Ambiente e comportamento
Dziga Vertov, L’occhio della rivoluzione, Mimesis, Milano 2011
King Vidor, Tree is a Tree, Longmans, Green and Co, Londra-New York-Toronto 1954
Paul Virilio, La velocità di liberazione
Paolo Virno, Quando la carne si fa verbo
Paolo Virno, Grammatiche della moltitudine
Robert Warshow, The Immediate Experience. Movies, Comics, Theatre and Other Aspects of Popular Culture
Alfred North Whitehead, Il concetto della natura
